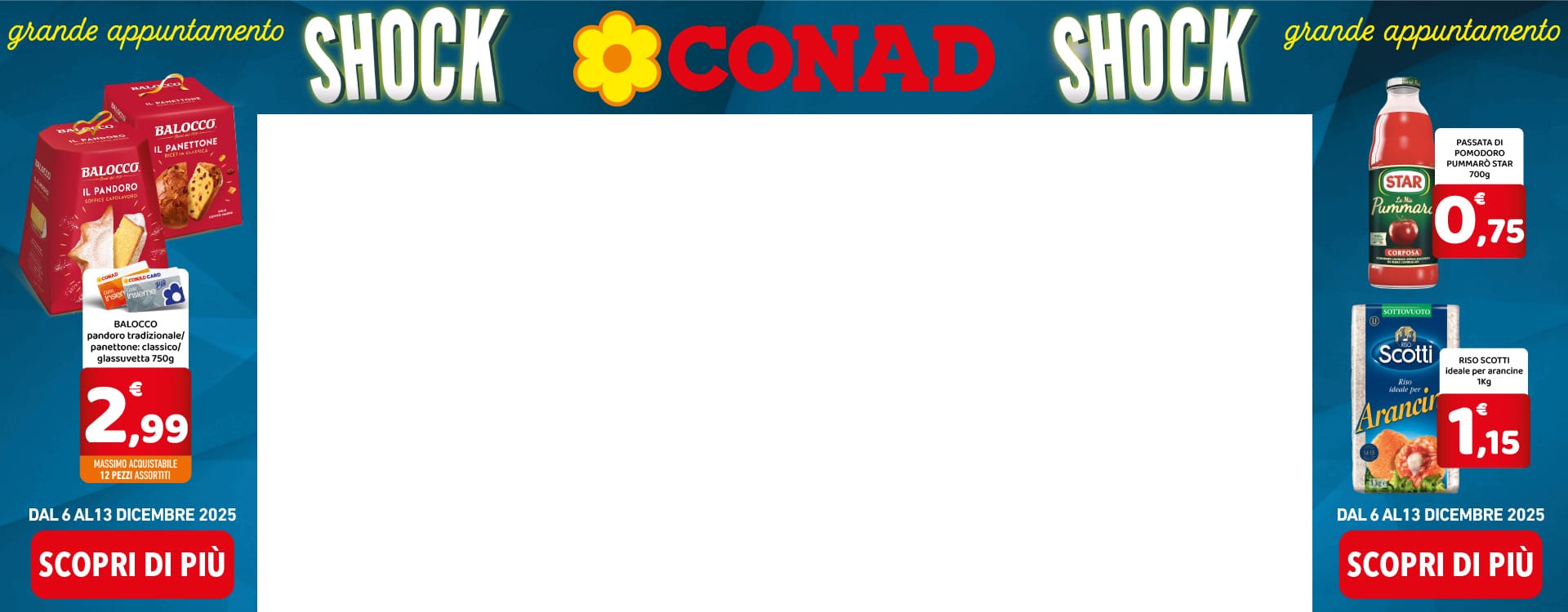Salendo la prima rampa di scale, c’è lo studio della signorina, la pittrice. Lei non c’è sempre, anzi spesso è fuori, che viaggia, perché fa mostre in tutto il mondo: al suo paese, all’America, unniegghiè. Ma quando è qua, è sempre contenta, passa davanti alla portineria e sorride e a me riempie il cuore di gioia. Io sorrido macàri e alzo una mano per salutarla, e lei che è così minuta che pare una picciridda, certe volte con i pantaloni bianchi tutti pittati, alza la mano e mi dice allò, che al suo paese usano salutare accussì, e io glielo dico pure: allò.
S’arricampò una mattina di qualche anno fa insieme a un suo amico, era in vacanza, tornava da una mostra importante a Nuova York, appena attraversò il portone si ci leggeva in faccia, rideva sola sola. Palazzo Cutò è così, fa questo effetto, è un poco magico: c’è chi s’innamora e se ne va e chi invece s’innamora e qua rimane, si piglia una casa e ci viene a vivere. E così fece Jenny, che il cognome non l’ho mai saputo dire Savì… Savil, io la chiamo Jenny l’Artista. L’amico della signorina il primo giorno che sono arrivati me lo disse, sicuro che le piace, perché i quadri che fa ci assomigliano a palazzo Cutò, io non è che l’ho capito cosa volesse significare, così dopo che si era trasferita da qualche settimana e la curiosità non mi era passata, una mattina con una calùnia ci sono salito. Aveva azzìzzato lo studio sotto e l’abitazione al piano di sopra. Lo studio erano due stanze una appresso all’altra, che se lo era sistemato bello vero, anche perché chissà quanti anni erano che era disabitato, anche se la confusione non si può capire: matite, pennelli, colori, fogli, foglietti c’era da mettersi le mai nei capelli se ne avessi avuto.
Che i quadri assomigliassero al palazzo, m’immaginavo che la signorina pittasse case arruzzulate, e invece no, io non ci vedevo già tanto bene, ma sicuro case sdirrupate non ne pittava. I quadri erano granni granni, alcuni arrivavano quasi al tetto, che lei di quanto era nica non si capiva come li pittasse. C’erano fimmìni e masculi nudi, ma non come a quelli di Michelangelo, erano corpi tutti sgummati, pieni di ferite, facce ammaccate, alcune lorde di sangue. Pareva che ognuno di quei corpi, non so come dire, pareva che quei masculi e quelle fimmìne, a cui la signorina dava forma, racchiudessero tutta la sofferenza del mondo. Manco tristezza, che quadri che fanno chiancìri ne ho visti e macàri mi sono messo a chiancìri, che mia moglie me lo dice sempre anche quando ci vediamo gli sceneggiati al primo canale che io sono un poco arma debole, ma questi facevano proprio arrizzare la carne, svutare lo stomaco, pareva che ogni quadro gridasse dolore, come le bestie quando vanno al macello.
Gambe, vrazza, panze, minne e facce che s’inturciuniavano, carne su carne che chiedeva pietà. La signorina tanto pulita e minuta era capace di pittare i peggiori incubi, le più tìnte paure di questa terra. Mi tramutò la faccia, sono diventato giarnu giarnu, e cominciai a vedere tutte cose nere. La signorina s’addunò, mi fece assittare e mi preparò un caffè. E glielo dissi che era brava, brava vero, anche se le cose che pittava erano timpulate in faccia, ma nel senso buono, perché parevano più vere delle cose vere e forse tanticchia lo avevo capito cosa volesse dire l’amico suo quando diceva che i quadri assomigliavano a palazzo Cutò: strati su strati, crepe, ferite che non riuscivano però a nascondere tanta bellezza. Poi, quando m’arripigghiai un altro poco, ci dissi pure un’altra cosa, che la prossima volta un caffè buono glielo offrivo io, dall’amico mio Baldo, vicino piazza Marina, che fa il migliore caffè di Palermo, anche se non vuole che lo si dica in giro.