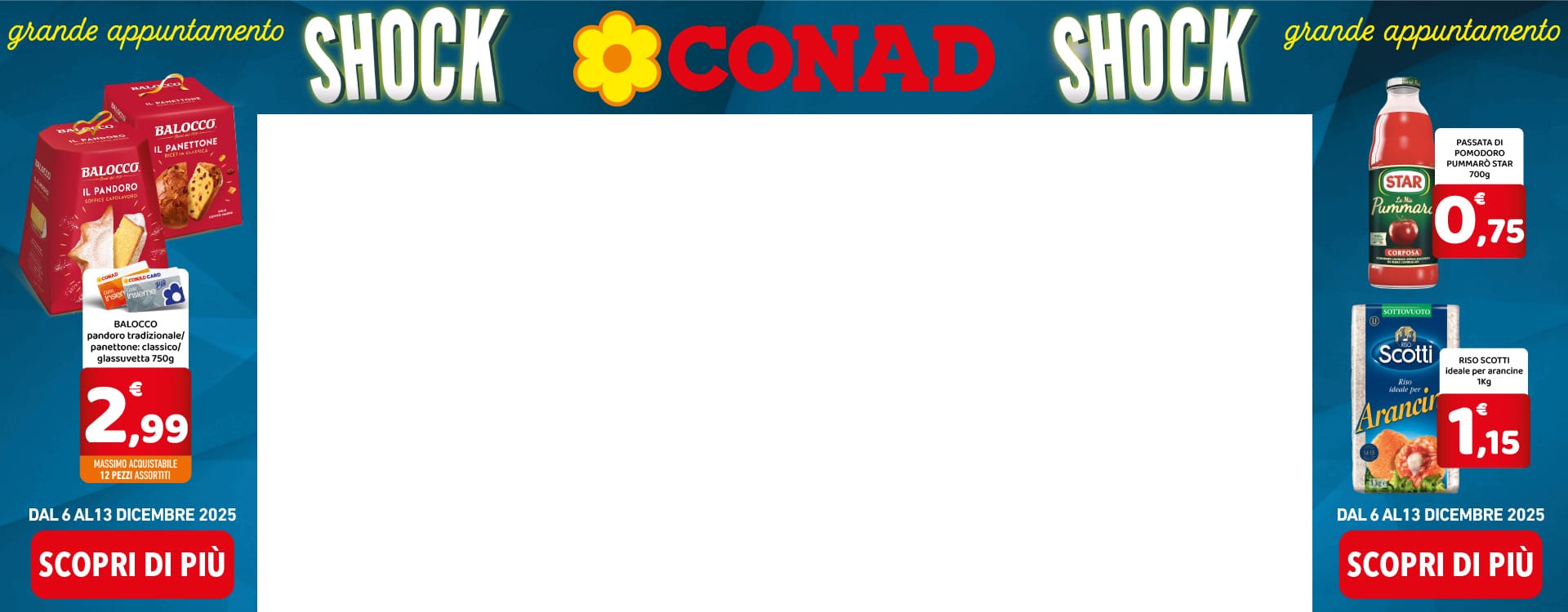Scoppiata la rivoluzione il 12 gennaio 1848, l’apparato militare borbonico, presente a Palermo, non fu in grado né di soffocarla né di contenerla.
Il capo militare, il luogotenente Luigi Nicola de Majo, duca di San Pietro, non poté fare altro che imbarcarsi per Napoli. Per la dinastia borbonica, apparentemente, tutto sembrava compromesso.
Eppure per Ferdinando qualche margine di recupero, almeno fino alla dichiarazione di decadenza del 13 aprile, c’era ancora, bastava che accettasse alcuni punti delle richieste che il comitato rivoluzionario gli indirizzò, fra cui “1. Che il Re avesse ripreso l’antico titolo di re delle Due Sicilie (e non del Regno delle Due Sicilie). 2. Che il suo rappresentante in Sicilia si fosse chiamato Vicerè e che fosse un membro della famiglia reale o un siciliano. 3. Che l’atto di convocazione del Parlamento, facesse parte della costituzione. 4. Che gli impieghi civili, militari ed ecclesiastici fossero appannaggio dei siciliani. 5. Che si consegnasse alla Sicilia la quarta parte della flotta, delle armi e del materiale di guerra o l’equivalente in denaro. 6. Che fossero restituiti i battelli doganali e postali acquistati per conto della Sicilia. 7. Che gli affari d’interesse comune fossero trattati e determinati dai due parlamenti. 8. Che in una lega politica o commerciale degli Stati italiani vi dovesse essere rappresentata la Sicilia come Stato indipendente. 9. Che la Sicilia potesse coniare moneta”.
Il re, però, non solo non volle accogliere nessuna delle richieste ma, addirittura, considerò offensive della sua maestà le stesse richieste. A convincere Ferdinando della giustezza della sua posizione fu proprio il Luigi De Majo che si impegnò, in modo alquanto sospetto, a sottolineare il discredito della monarchia che sarebbe seguito a quella che definiva una resa.
Un giornale del tempo, uno dei 160 che furono pubblicati nel periodo della rivoluzione, parlo della “Gazzetta”, il n°3 del 23 febbraio 1848, in un articolo molto pungente ci racconta il perché di questa insistenza. Ne riportiamo qui una parte del testo, sapido di pungente ironia. Ci racconta la Gazzetta “…il perché [parla dell’insistenza di De Majo] è un segreto e prego di non tradirlo – coll’unità del Parlamento e la centralizzazione [cioè lo spostamento a Napoli] i Pari e i Deputati sarebbero obbligati a recarsi a Napoli, ove dovrebbero alloggiare negli alberghi i più rinomati per l’onore della rappresentanza. Or De Majo essendo proprietario di rinomate locande troverebbe rifarsi di quel tanto, che sventuratamente gli è venuto meno per quella buona memoria della luogotenenza gloriosamente perduta”. In poche parole, dietro, la nobiltà dei concetti espressi a tutela della dignità della dinastia, ci stavano tanto miseri che gretti interessi di bottega. Conclude, provocatoriamente, l’articolo della Gazzetta: “Bravo De Majo! Tu sei accorto locandiere diplomatico, come fosti luogotenente locandiere!”.
Che dire se non, Nihil sub solenovum.