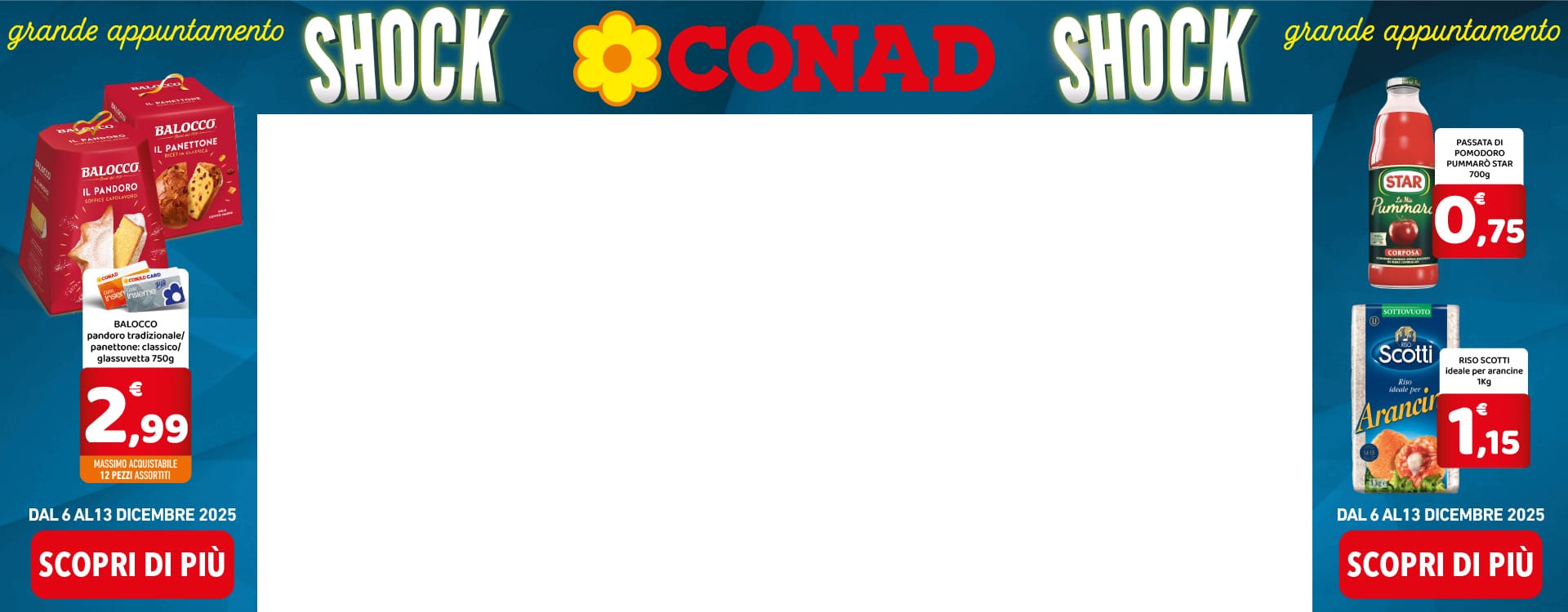Negli ultimi mesi Palermo vive una tensione crescente tra risse, aggressioni e più di un omicidio che ha scosso la città. Così la risposta arriva nel modo più immediato e riconoscibile ovvero con più forze dell’ordine, più controlli, più telecamere. È la grammatica classica della sicurezza in Italia, dove ogni emergenza sociale si traduce in un dispiegamento visibile di uomini e mezzi. Ma è davvero questa la strada giusta?

Si tratta sicuramente di un intervento importante, che arriva dopo settimane di tensione e dopo l’omicidio di Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni ucciso per aver tentato di fermare un pestaggio. Palermo si è risvegliata sconvolta e lo Stato ha risposto con più uomini, più controlli, più tecnologia. Ma la domanda resta: più sicurezza o solo più sorveglianza?
Il limite delle risposte d’emergenza

Come spesso accade, di fronte a un fatto grave la reazione è immediata e visibile. Si aumenta la presenza delle forze dell’ordine, si creano “zone rosse”, si promettono nuove telecamere. È la risposta più rapida, quella che rassicura. Ma anche quella che rischia di confondere la presenza dello Stato con la vicinanza dello Stato.
Non è un problema solo palermitano. L’Italia da anni punta su politiche di “visibilità della sicurezza”. L’operazione Strade Sicure, avviata nel 2008, continua a impegnare migliaia di militari per presidiare strade, piazze, stazioni. Un presidio che nel tempo è diventato simbolico più che efficace. La stessa Corte dei Conti, in una sua relazione, ha sottolineato che “non è possibile verificare e valutare il positivo impatto dei risultati operativi” di tali impieghi. Tradotto: la presenza dei soldati non ha dimostrato di ridurre realmente i reati.
Gli studi internazionali: più divise non significa più sicurezza
Negli ultimi anni, numerose ricerche hanno messo in discussione l’efficacia delle strategie di militarizzazione urbana come risposta alla criminalità.
![]() Un caso emblematico arriva da Cali, in Colombia, dove interi quartieri furono posti sotto controllo militare dopo un’ondata di violenza. Uno studio sperimentale — “Mano Dura: An Experimental Evaluation of Military Policing” — ha mostrato che, durante e dopo l’intervento, non si è registrata alcuna riduzione significativa dei reati, ma solo uno spostamento della criminalità verso altre aree.
Un caso emblematico arriva da Cali, in Colombia, dove interi quartieri furono posti sotto controllo militare dopo un’ondata di violenza. Uno studio sperimentale — “Mano Dura: An Experimental Evaluation of Military Policing” — ha mostrato che, durante e dopo l’intervento, non si è registrata alcuna riduzione significativa dei reati, ma solo uno spostamento della criminalità verso altre aree.
I risultati emersi dallo studio sono significativi e preoccupanti. Anzi, dopo la sua conclusione, si è osservato un incremento delle violazioni dei diritti umani, in particolare da parte delle forze di polizia.
Anche negli Stati Uniti, una delle analisi più citate sul tema è quella condotta da Jonathan Mummolo e pubblicata su PNAS nel 2018.
Lo studio ha esaminato oltre 9.000 dipartimenti di polizia e ha concluso che la militarizzazione non riduce i tassi di criminalità né migliora la sicurezza degli agenti, ma può anzi minare la fiducia dei cittadini nelle forze dell’ordine.
Infine, i rapporti di UN-Habitat, in particolare il World Cities Report 2020 e il Global State of National Urban Policy 2021, evidenziano l’importanza di fattori strutturali e sociali nella costruzione di una sicurezza urbana sostenibile. Questi studi sottolineano che la coesione sociale, l’accesso all’istruzione, la presenza di servizi di prossimità e la partecipazione civica sono elementi fondamentali per prevenire la criminalità e costruire comunità resilienti.
 Inoltre, i rapporti evidenziano che città che investono in inclusione e partecipazione civica registrano tassi di criminalità più bassi e percezioni di sicurezza più elevate. Al contrario, interventi puramente repressivi, come un incremento dei militari o l’installazione massiva di telecamere, mostrano effetti limitati nel lungo periodo e possono generare tensioni sociali, minando la fiducia tra cittadini e istituzioni.
Inoltre, i rapporti evidenziano che città che investono in inclusione e partecipazione civica registrano tassi di criminalità più bassi e percezioni di sicurezza più elevate. Al contrario, interventi puramente repressivi, come un incremento dei militari o l’installazione massiva di telecamere, mostrano effetti limitati nel lungo periodo e possono generare tensioni sociali, minando la fiducia tra cittadini e istituzioni.
In altre parole, secondo UN-Habitat, la vera sicurezza urbana si costruisce “dal basso”, investendo in capitale sociale, partecipazione civica e servizi accessibili, piuttosto che “dall’alto”, affidandosi esclusivamente alla sorveglianza e alla repressione. Questi dati rafforzano l’idea che lo sviluppo urbano sostenibile e inclusivo non sia solo una questione di infrastrutture o controllo, ma di politiche integrate che mettano al centro le persone e la vita comunitaria.
Palermo e il suo paradosso
 Purtroppo, Palermo conosce bene questo copione. Dopo ogni fatto di sangue si invocano più pattuglie e più controllo, ma raramente si parla di scuola, lavoro, cultura. Si presidiano le piazze, ma non le cause del disagio. Quartieri come Zen, Brancaccio, lo Sperone restano ai margini, con poche opportunità e molte ferite ancora aperte.
Purtroppo, Palermo conosce bene questo copione. Dopo ogni fatto di sangue si invocano più pattuglie e più controllo, ma raramente si parla di scuola, lavoro, cultura. Si presidiano le piazze, ma non le cause del disagio. Quartieri come Zen, Brancaccio, lo Sperone restano ai margini, con poche opportunità e molte ferite ancora aperte.
Aumentare la presenza delle forze dell’ordine può servire nell’immediato, ma la sicurezza vera si costruisce nei servizi, nelle relazioni e nelle occasioni di crescita di una città che, da troppi anni, ha scelto di dimenticare e confinare ai margini interi quartieri e generazioni. Luoghi dove l’assenza di opportunità ha preso il posto dello Stato e dove la sfiducia è diventata la regola.
Quando il tuo Paese ti dimentica, il silenzio si trasforma in rabbia, e la rabbia cerca voce. È lì che nasce la voglia di rivalsa, il bisogno di essere visti, anche attraverso la forza e le armi. Per chi cresce senza alternative, senza spazi, senza qualcuno che gli riconosca valore, l’unico modo per esistere diventa imporsi. E allora l’arma non è solo uno strumento di violenza ma diventa un simbolo, il tentativo estremo di gridare “ci sono anch’io” in una società che ha scelto di voltarsi dall’altra parte.
Quando lo Stato deve mandare i militari per proteggere i propri quartieri, è il segno che ha smesso di farlo con gli strumenti civili come la scuola, il lavoro, la fiducia. Ed è lì, forse, che Palermo deve tornare a guardare se vuole sentirsi davvero al sicuro.