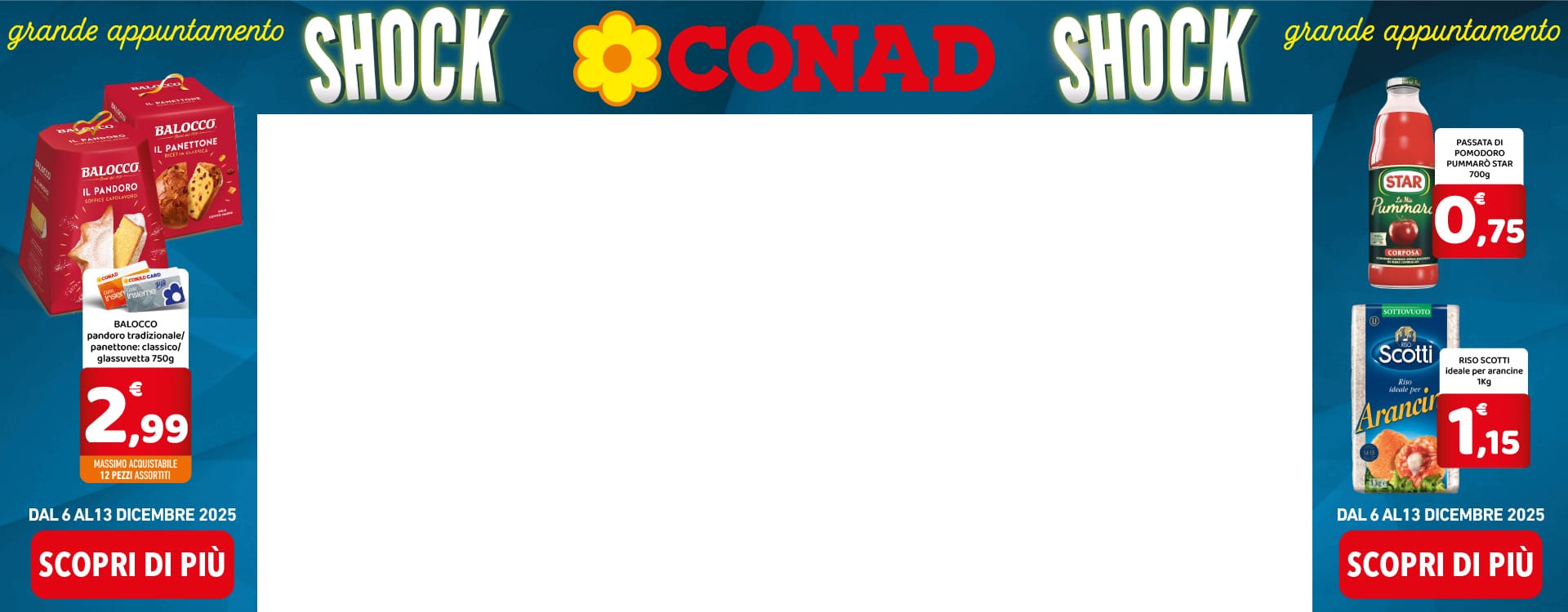Quando la paura si trasmette in Europa tra cronaca, pressione emotiva e fragilità collettiva. Tre crisi apparentemente scollegate – i blackout energetici che hanno colpito Spagna e Portogallo, la guerra in Ucraina e l’aumento della violenza urbana – si intrecciano e condizionano negativamente la percezione di sicurezza dei cittadini europei e italiani.
IlSicilia.it ha voluto analizzare come questi fenomeni contribuiscano alla costruzione di un clima diffuso di incertezza, interrogando le loro cause comuni, gli effetti sulla società e provando a ragionare anche sulle possibili vie d’uscita.
Crisi multiple e insicurezza percepita in Europa: shock “convergenti”
Un lampo improvviso, poi il buio. Milioni di cittadini tra Spagna e Portogallo si ritrovano senza corrente, senza connessione, senza riferimenti. Intanto, a migliaia di chilometri, i cieli dell’Ucraina continuano a essere solcati da missili, mentre nelle metropoli europee cresce l’eco di aggressioni, sparatorie, risse tra gang.
Eventi diversi, distanti, ma collegati da un filo invisibile: la crescente sensazione, per milioni di cittadini europei, che il sistema stia perdendo coesione. Che la stabilità, un tempo data per scontata, sia diventata fragile come vetro.
Negli ultimi anni l’Europa ha conosciuto una concatenazione di crisi senza precedenti. Dopo la pandemia, che ha minato profondamente le certezze sanitarie e relazionali, sono arrivate le guerre alle porte dell’Unione, le crisi energetiche, l’inflazione, i disordini sociali.

E oggi, episodi apparentemente scollegati – come un blackout su larga scala, un’escalation militare o un aumento della violenza urbana – generano un impatto profondo sulla psiche collettiva.
Non si tratta solo di rischi reali, ma di rischi percepiti, che modellano il nostro modo di vivere, di votare, di informarci e perfino di relazionarci con gli altri. Aumenta la sfiducia, la paura dell’altro, la tentazione di chiudersi in comunità ristrette. La sensazione che lo Stato, l’Europa, il “sistema” non riescano più a garantire sicurezza, diritti, servizi.
Questo articolo prova a tracciare un filo tra questi tre fenomeni emblematici per comprendere come questi alimentino una nuova insicurezza europea, sociale prima ancora che politica. E lo fa partendo dalla percezione dei cittadini, perché è lì che la tenuta di una società si gioca.
Il buio oltre la luce: il blackout iberico e la “vulnerabilità tecnologica” dell’Europa
Il 19 marzo 2024, un guasto tecnico a un’infrastruttura della rete ad alta tensione in Spagna ha generato un blackout su larga scala, colpendo più di un milione di persone tra la penisola iberica e il sud della Francia.
Treni fermi, semafori spenti, ospedali in allerta. Poche ore dopo, un evento analogo ha interessato anche alcune aree del Portogallo. Le autorità hanno parlato di “problema di trasmissione”, ma l’effetto simbolico è andato ben oltre il disservizio momentaneo: per molti cittadini, quello è stato il segno tangibile che il nostro sistema energetico è vulnerabile. E con esso, tutto il modello di società che vi si regge sopra.

In un mondo iperconnesso, dipendente dall’elettricità e dai flussi digitali, un blackout non è più solo un’interruzione del servizio: è una crepa nella percezione di continuità e sicurezza. Quando la luce si spegne, a spegnersi è anche l’illusione del controllo totale sul presente.
Non è un caso che sociologi come Ulrich Beck, nella sua teoria della “società del rischio”, abbiano messo in guardia già negli anni ‘80 su questo punto: il rischio nella modernità non è tanto legato a pericoli esterni (come un’invasione o una carestia), quanto a disfunzioni interne al sistema che noi stessi abbiamo costruito. E il rischio energetico ne è l’emblema.
Nonostante l’elevata sofisticazione dei sistemi elettrici europei, la rete rimane fragile, interdipendente, esposta sia a guasti tecnici che ad attacchi esterni, come quelli informatici. Con l’aggravarsi delle tensioni internazionali e il passaggio a nuove fonti di energia, questa fragilità si amplifica.
Non è un caso che in molti Paesi europei si stia tornando a parlare di piani di emergenza civile, con raccomandazioni alle famiglie su come affrontare eventuali blackout prolungati: scorte d’acqua, radio a batterie, candele, kit di sopravvivenza.
La società digitale, che si voleva “smart” e resiliente, si scopre impreparata alla disconnessione. Una vulnerabilità che va oltre l’aspetto tecnico, toccando corde profonde dell’immaginario collettivo: paura, isolamento, senso d’impotenza.
Il blackout diventa così una metafora potente della crisi di affidabilità percepita delle infrastrutture, ma anche della crisi di fiducia verso le istituzioni chiamate a gestirle.

In Italia, sebbene eventi analoghi non abbiano (per ora) colpito su larga scala, la preoccupazione cresce. Secondo un sondaggio IPSOS condotto nel gennaio 2024, oltre il 60% degli italiani teme un’interruzione prolungata dei servizi energetici nei prossimi due anni, complice anche l’eco della guerra in Ucraina e i timori legati al sabotaggio delle infrastrutture critiche.
Ecco allora che il blackout si carica di un significato nuovo: non più incidente locale, ma sintomo sistemico, percepito come spia di un mondo che non riesce più a garantire continuità, né sicurezza. E in questa percezione si insinua il seme dell’insicurezza sociale, prima ancora che tecnica.
Guerra e distanza: il conflitto in Ucraina e la geopolitica che “entra in casa”
Il 24 febbraio 2022, con l’invasione russa dell’Ucraina, l’Europa ha assistito al ritorno della guerra nel continente. Un evento epocale, che ha rotto un tabù profondo: la convinzione che la guerra, almeno sul suolo europeo, fosse un ricordo del passato.
Da quel giorno, la sicurezza non è più stata la stessa. Ma non solo per le bombe che cadono su Kyiv o Kharkiv. Anche – e forse soprattutto – per l’effetto psichico e percettivo che il conflitto ha generato nei cittadini dei Paesi vicini e in Europa in generale.
Le prime settimane di guerra hanno visto un’Europa compatta: accoglienza ai profughi, solidarietà, sanzioni. Ma col passare del tempo e degli anni è emersa un’altra faccia: la paura della guerra che si avvicina, che tocca gli approvvigionamenti, le bollette, il lavoro, i rapporti tra comunità. Si è fatta strada una domanda silenziosa: “E se domani toccasse a noi?”.

Sociologicamente, il conflitto ha agito come un acceleratore di consapevolezze rimosse: l’interdipendenza energetica, la fragilità delle catene logistiche, la fine dell’illusione che i confini dell’Europa fossero impermeabili. Il ritorno della guerra ha messo in crisi l’idea stessa di “ordine liberale globale”, costringendo l’Europa a riconsiderare le proprie priorità, la propria difesa, il proprio futuro.
Questa trasformazione non è rimasta confinata ai palazzi del potere. Ha inciso anche nel vissuto quotidiano dei cittadini, soprattutto in termini di insicurezza diffusa.
Secondo l’Eurobarometro del 2023, la percentuale di europei che percepiscono la guerra come “minaccia concreta per la loro vita” è passata dal 24% al 41% in due anni. In Italia, il dato è ancora più alto: il 47% si dice “molto preoccupato” per un possibile allargamento del conflitto.

Ma c’è di più. La guerra ha innescato una polarizzazione nella comunicazione e nell’opinione pubblica. Tra sostenitori convinti della causa ucraina e scettici sull’invio di armi, tra chi invoca la diplomazia e chi chiede fermezza, si è aperta una frattura che ha reso il dibattito sempre più teso e identitario.
La geopolitica, da questione lontana e tecnica, è diventata materia da social network, da talk show, da bar. Ma con essa è arrivata anche “l’ansia geopolitica”, una nuova forma di insicurezza postmoderna, che si nutre di notizie, di escalation possibili, di minacce nucleari rilanciate dai media.
Per alcuni, il conflitto è diventato una guerra fantasma: non la si vive sulla pelle, ma la si assorbe ogni giorno tramite flussi d’informazione, bollettini, immagini forti. E questo ha effetti psicologici misurabili.
Gli psicologi parlano di “eco-ansia geopolitica”, una condizione crescente in particolare tra giovani e adolescenti, che si sentono impotenti di fronte a eventi giganteschi, su cui non hanno alcun controllo.

Anche la fiducia nelle istituzioni ne risente. La guerra, infatti, accentua le aspettative verso lo Stato, l’Ue, la Nato. Ma quando queste risposte sono percepite come ambigue, lente, o interessate, si produce una frustrazione latente, che può sfociare in disillusione o in rabbia.
Il conflitto in Ucraina, pur non toccando militarmente l’Italia, ha dunque avuto un impatto profondo sul piano emotivo e sociale. Non si tratta solo di geopolitica: si tratta di come, oggi, milioni di cittadini europei guardano il futuro con meno certezze, e con più paura. Una paura che diventa terreno fertile per nuove insicurezze, nuove narrazioni, nuove fragilità democratiche.
Violenza urbana e insicurezza diffusa nelle città: la cronaca come specchio della “frattura sociale”
Nell’ultimo biennio, l’Europa ha registrato un incremento di episodi di violenza urbana, risse tra giovanissimi, aggressioni a sfondo razziale o sessista, esplosioni di rabbia incontrollata in spazi pubblici e nei trasporti.
In Italia, il fenomeno è particolarmente evidente nelle grandi città, dove la cronaca riporta quasi quotidianamente notizie di pestaggi, rapine, atti vandalici, baby gang.
Ma non è solo la frequenza a colpire: è la percezione di un’escalation fuori controllo, che molti cittadini vivono come segnale di un cedimento strutturale della convivenza civile.

Secondo il Censis, tra il 2022 e il 2024 l’indice di insicurezza percepita in Italia è salito del 28%, nonostante i dati oggettivi della criminalità non indichino un’impennata generalizzata. Questo scarto tra realtà e percezione è uno degli elementi chiave per capire il presente: non è tanto la quantità della violenza a mutare, quanto la sua capacità di orientare il sentimento collettivo.
Nelle metropoli europee, fenomeni come le rivolte giovanili in Francia, gli scontri etnici a Berlino, i casi di violenza di gruppo in Spagna e i femminicidi e le baby gang violente in Italia sono letti da sociologi come sintomi di una tensione profonda, spesso legata a fragilità sociali, esclusione educativa, precarietà, mancanza di prospettive.

Eppure, per chi osserva da fuori, questi episodi tendono a fondersi in un’unica narrativa: quella di un’Europa che sta perdendo il controllo delle sue città.
È la logica della “pan-insicurezza”, una categoria elaborata dal sociologo francese Laurent Mucchielli: la società viene attraversata da una sensazione generalizzata di pericolo, alimentata dai media, dalla politica e da dinamiche psicologiche collettive. Ogni fatto violento diventa metafora di qualcosa di più grande, di un disagio che va oltre il singolo episodio.
A questo si aggiunge la nuova cassa di risonanza dei social network, dove ogni video di un’aggressione, ogni testimonianza, ogni frame violento diventa virale. L’algoritmo privilegia l’emozione, il sensazionalismo, e costruisce così una narrazione frammentata ma potente: “il mondo fuori è pericoloso, nessuno è al sicuro, le autorità non bastano”.

Il risultato è un cortocircuito tra cronaca e identità urbana. Luoghi un tempo simbolo di apertura e multiculturalismo (come Milano, Parigi o Barcellona) diventano teatro di tensioni. Cresce la richiesta di ordine, sicurezza, repressione.
E al tempo stesso si accentua la sfiducia: verso lo Stato, verso il “prossimo”, verso le nuove generazioni.
In questo contesto, l’insicurezza si trasforma da paura privata a discorso pubblico, e diventa un vettore politico. Si moltiplicano le retoriche securitarie, i proclami contro “il degrado”, le richieste di militarizzazione del territorio. Ma raramente si affrontano le cause profonde, come la povertà educativa, la disuguaglianza abitativa, la marginalità culturale.

Il rischio, evidenziato anche dal sociologo Zygmunt Bauman, è che la società finisca per accettare un paradigma di “sicurezza liquida”: instabile, emotiva, fondata più sulla percezione che sulla realtà. Una sicurezza costruita sull’ansia, più che sull’analisi.
Così, nel volto alterato delle nostre città, si riflette una frattura più ampia: quella tra il patto sociale e la sua credibilità.
Un tema che, al pari dei blackout e della guerra, incide profondamente sulla coesione collettiva e sulla fiducia nel futuro.
“L’interconnessione” delle insicurezze: segni di una crisi di tenuta sociale
Questi tre fenomeni distinti, con cause e sviluppi diversi, nel vissuto collettivo confluiscono quindi in una stessa matrice percettiva: quella dell’insicurezza generalizzata. È qui che si gioca la posta più alta per le società europee, e in particolare per l’Italia: la capacità o meno di resistere alla pressione psicologica e sociale di queste nuove insicurezze convergenti.
L’intersezione tra questi fattori ha un effetto “moltiplicatore”. Un blackout può essere letto non solo come un disservizio, ma come segno di fragilità sistemica; una guerra in Ucraina diventa metafora della vulnerabilità geopolitica europea; un’aggressione in metro si trasforma nel simbolo di un ordine sociale che si disgrega.
La realtà e la percezione si intrecciano, creando un clima di allarme diffuso che altera il modo in cui le persone si relazionano tra loro, con lo Stato, con l’informazione.

I tre elementi – crisi energetica, conflitto militare e violenza urbana – dialogano tra loro nel subconscio collettivo, agendo su diverse leve ma con lo stesso effetto: l’erosione della fiducia. Non solo verso le istituzioni, ma anche verso la possibilità stessa di un futuro stabile, vivibile, condiviso.
Il sociologo Ulrich Beck parlava di “società del rischio”: oggi potremmo parlare di società della fragilità percepita, dove ogni evento critico assume il volto del “segno dei tempi”.
Questa convergenza ha anche una dimensione culturale e narrativa. I media – tradizionali e digitali – enfatizzano l’urgenza, l’eccezionalità, l’allarme. In assenza di contropesi narrativi, l’eccezione diventa la norma, e la quotidianità assume i contorni di un tempo sospeso, insicuro, imprevedibile.
La memoria collettiva recente – pandemia, crisi climatica, instabilità economica – agisce da sfondo permanente a ogni nuovo evento destabilizzante. Non è più la singola crisi a preoccupare, ma la loro somma.

In questo contesto, emergono due reazioni opposte e complementari: da un lato l’adattamento apatico, una sorta di anestesia emotiva di fronte alla complessità; dall’altro la radicalizzazione, che trova nella paura un carburante per richieste di autorità, ordine, chiusura.
Entrambe le risposte indeboliscono la tenuta democratica. La prima perché disinnesca il coinvolgimento civico, la seconda perché alimenta derive populiste e securitarie.
L’Italia, in particolare, è un laboratorio sensibile per osservare queste dinamiche. La presenza di forti disuguaglianze territoriali, un tessuto urbano frammentato e una cronica sfiducia istituzionale fanno sì che ogni nuova insicurezza trovi un terreno già vulnerabile. Il blackout in Portogallo e Spagna, pur se geograficamente distante, è rimbalzato con forza nell’immaginario nazionale.
Così come la guerra in Ucraina ha suscitato timori immediati anche tra chi, formalmente, non è esposto al conflitto. La percezione dell’insicurezza non segue le mappe geopolitiche, ma quelle emotive.

Il rischio più profondo, però, è quello della normalizzazione dell’insicurezza. Quando vivere nella paura diventa la nuova forma del quotidiano, la società smette di progettare e si limita a reagire.
Si riducono i margini della solidarietà, si sgretolano le reti di fiducia, si esaspera il conflitto tra gruppi.
È in questo vuoto che possono crescere le fratture più pericolose: tra centro e periferia, tra cittadini e Stato, tra generazioni.
Questa convergenza di shock non è solo una coincidenza temporale, ma una manifestazione complessa della crisi di tenuta sociale dell’Europa contemporanea. Un campanello d’allarme che chiama giornalisti, studiosi e decisori a una riflessione profonda sul presente e, soprattutto, sul tipo di futuro che vogliamo costruire.