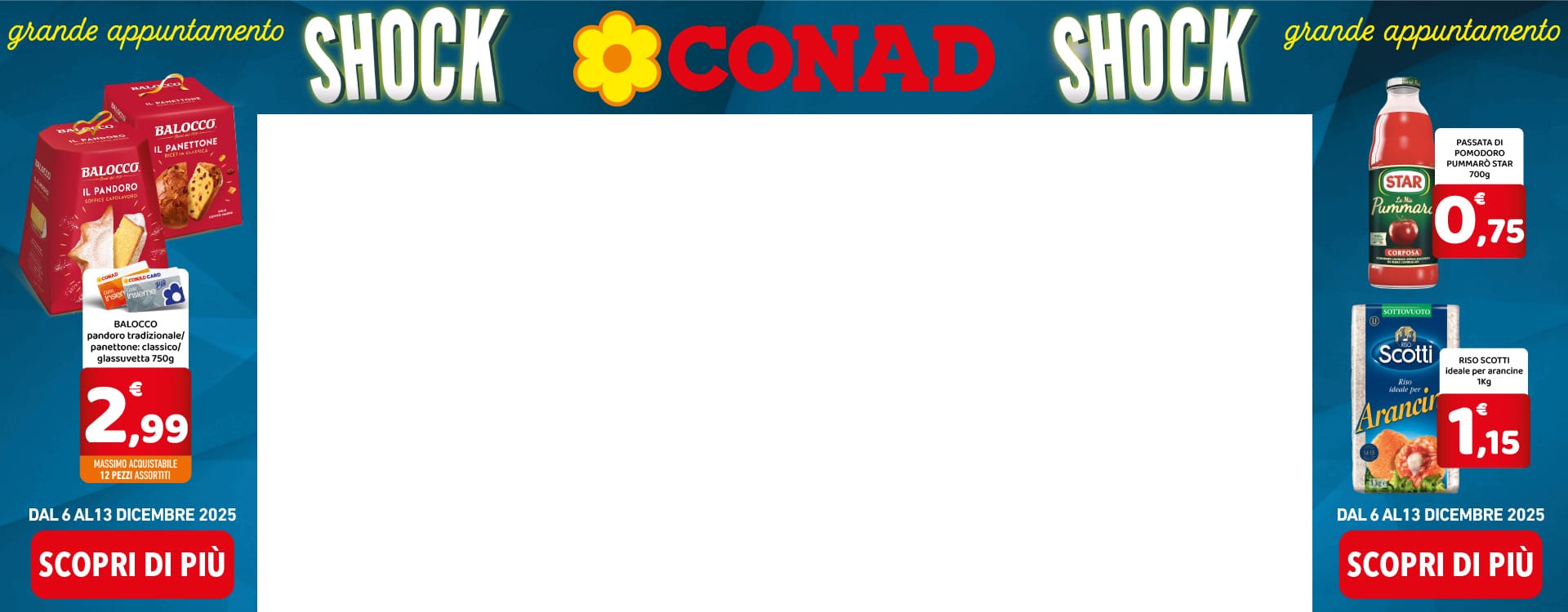Daniela Igliozzi, attrice, scrittrice, drammaturga, pittrice, in una ricca intervista ci parla della sua arte.
Ciao Daniela, benvenuta e grazie per la tua disponibilità. Se volessi presentarti quale artista poliedrica quale sei, cosa diresti di te?
“Grazie a te Andrea e ai lettori che vorranno leggerci su questa bellissima rivista. Vuoi sapere della mia poliedricità? Dovuta sempre al caso, quel signore che in silenzio ci comanda. Feci la prima mostra, estemporanea, una estate, ritraendo le maestose mura ciclopiche di Alatri. Già dipingevo ma quella volta mi dettero un premio. Un’altra estate interpretai la Salomé di Oscar Wilde con degli amici divertendomi un mondo, oltre che a recitare, a confezionarmi il costume e il ventaglio di scena raccattando in un pollaio penne di gallina. Mio padre mi portò al Sistina a vedere uno spettacolo di flamenco col mitico Enrique el Cojo, ballerino piccolo, grassottello e cojo, cioè zoppo. Ma non esistono limiti al duende, quando c’è. Lo aveva capito bene Federico García Lorca, che dedicò anni allo studio di quella che definì “la più grande invenzione del popolo spagnolo”. Grande arte, grandiosa follia del ritmo. Rimasi affascinata. Feci di tutto per trovare qualcuno che mi insegnasse, non era facile allora, a differenza di oggi che il flamenco si studia dappertutto. Volai a Jerez de la Frontera per partecipare a lezioni di Matilde Coral, bailaora storica. Continuai poi a Roma sotto la guida di Reina Lopez la Blanca. Ero vittima della prepotenza di una amica ma non riuscivo a fare le mie ragioni, non ero in grado di argomentare lasciando a lei il potere di sottomettermi. Non riuscivo a difendermi. Cominciai a scriverne cercando di analizzare fatti e personaggi. Da allora le detti filo da torcere. La cosa mi piacque. Siamo ancora amiche. Ma alla pari. Ripresi lo scritto e ne feci un piccolo romanzo. Glielo feci leggere. Non si accorse che dentro c’era anche lei. Scrivendo capii quanto sia importante sapersi esprimere con la parola per non farsi mettere i piedi sulla testa. “Sapere per potere” diceva il pittore Gustave Courbet. “Sapersi esprimere aiuta a difendersi” diceva Don Milani. Scoprii la potenza della scrittura che traduce un pensiero, una sensazione, una fugace impressione, un sentimento – che attraverso di essa possono essere veicolati – e non l’ho più abbandonata. Avevo imparato più con questa esperienza che non a scuola. Il flamenco mi ha fatto conoscere Federico García Lorca, ne lessi l’opera omnia, scrissi un testo di teatro sulla sua vita e la sua opera, con musica flamenca, poesie, stralci di sue opere di teatro, le sue interviste, i suoi pensieri e considerazioni sul teatro, su cosa sia la poesia, i suoi racconti di viaggio, la sua giovinezza e le sue amicizie, l’amore per le persone umili e per i poveri, il suo intimo dramma per la inconfessabile omosessualità, l’impossibilità d’amare, il dramma del fascismo, la fucilazione dopo tre giorni e tre notti in cui gli fecero bere cafè, mucho cafè, secondo la procedura che si usava per i condannati a morte. E ho continuato a scrivere in forma drammaturgica“.
La tua carriera cinematografia nel cinema italiano che conta è davvero impressionante: Diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, hai fatto tantissimo Cinema, Teatro classico e leggero, TV, Radio, Doppiaggio iniziato già dai primi ’60 con Stefano Sibaldi alla ARS-Associazione Romana Sincronizzatori. Hai studiato danza, ballo, baile Flamenco. Sei stata campionessa regionale di Tennis. E adesso ti dedichi alla pittura, alla calcografia d’arte, alla scrittura di testi per il teatro e di romanzi. Ci racconti in poche righe la tua carriera artistica di grande successo? Cosa ti senti di raccontare ai nostri lettori?
 “Al Centro Sperimentale di Cinematografia rimasi sorpresa nel vedere che i miei voti, al diploma, erano i più alti. Liliana Cavani mi aveva scelto per girare il suo short d’esame Le ore inquietanti, sul tema della diversità. Purtroppo ancora attualissimo. Recitavo con l’attore senegalese Samb Abacacar, già interprete del famoso Questione di pelle. Poco dopo debuttavo alla Rai col romanzo sceneggiato Tom Jones ma pochi giorni dopo si interruppe. Gli attori erano entrati in sciopero. Fu l’inizio di battaglie importanti a difesa della categoria, si costituì la Sai, Società Attori Italiani; colui che anni dopo divenne mio marito, Armando Bandini, straordinario interprete e caratterista, e doppiatore, ne era vice-presidente. Era l’epoca dei grandi fermenti, i nomi famosi dello spettacolo si mossero per primi, eravamo agguerriti, volevamo anche noi i nostri diritti, fino ad allora sconosciuti. Di due spettacoli, nello stesso giorno, ne veniva pagato solo uno, non esistevano straordinari, neanche alla Rai, il Voce-Volto, promosso da mio marito, non si era mai immaginato. Ne ottenemmo, di diritti, con fatica, scioperi, assemblee, resoconti sui giornali. Quello dell’attore è il mestiere precario per antonomasia si sa, ma almeno ci siano riconosciuti i diritti. Dopo qualche anno qualcosa cominciò a andare storto. La Sai nostra diventò del Sindacato – Il Sai –. Ora siamo ridotti peggio di prima. Peccato“.
“Al Centro Sperimentale di Cinematografia rimasi sorpresa nel vedere che i miei voti, al diploma, erano i più alti. Liliana Cavani mi aveva scelto per girare il suo short d’esame Le ore inquietanti, sul tema della diversità. Purtroppo ancora attualissimo. Recitavo con l’attore senegalese Samb Abacacar, già interprete del famoso Questione di pelle. Poco dopo debuttavo alla Rai col romanzo sceneggiato Tom Jones ma pochi giorni dopo si interruppe. Gli attori erano entrati in sciopero. Fu l’inizio di battaglie importanti a difesa della categoria, si costituì la Sai, Società Attori Italiani; colui che anni dopo divenne mio marito, Armando Bandini, straordinario interprete e caratterista, e doppiatore, ne era vice-presidente. Era l’epoca dei grandi fermenti, i nomi famosi dello spettacolo si mossero per primi, eravamo agguerriti, volevamo anche noi i nostri diritti, fino ad allora sconosciuti. Di due spettacoli, nello stesso giorno, ne veniva pagato solo uno, non esistevano straordinari, neanche alla Rai, il Voce-Volto, promosso da mio marito, non si era mai immaginato. Ne ottenemmo, di diritti, con fatica, scioperi, assemblee, resoconti sui giornali. Quello dell’attore è il mestiere precario per antonomasia si sa, ma almeno ci siano riconosciuti i diritti. Dopo qualche anno qualcosa cominciò a andare storto. La Sai nostra diventò del Sindacato – Il Sai –. Ora siamo ridotti peggio di prima. Peccato“.
“Quanto al tennis cominciai sotto casa dove c’era un campo che affittavano a ore. Dopo qualche anno vinsi la Coppa Lazio per il Tennis Club Gianicolo, torneo a squadre, battendo in finale il Tennis Club Parioli, il circolo più esclusivo della Roma bene. Come da tabellone si giocava a casa loro. Tre sudatissimi set contro la famosa Conklin con un tifo-contro che avrebbe annientato un Federer e il doppio che giocai praticamente da sola; la mia compagna dopo aver perso il suo singolo non riusciva a infilarne una. Ed era bravissima. Ma fu tradita dalla concentrazione, quel giorno l’aveva tradita. Portai a casa e misi tra le altre la bellissima Coppa e la medaglia d’oro”.
“Mi fa piacere che tu mi chieda dell’incisione. Non la pratico più e ne ho grande nostalgia. Lì dovetti scegliere. O lei o tutto il resto. La libertà che avevo praticato con molta allegria dedicandomi a più di una cosa lì si interruppe. Mi ci dedicai qualche anno, dopo averla imparata presso scuole rinomate. Facemmo la prima mostra portando a Venezia le nostre grandi opere – per dimensione s’intende – imballate con estrema cura per farle arrivare sane e salve, in gondola nell’ultimo tratto del lungo viaggio, alla Galleria del Teatro La Fenice. Avevo contagiato anche Armando; ci eravamo incontrati al doppiaggio di Bia, il primo cartone animato giapponese, una lunga serie. Lui aveva da poco perso la moglie, Emma Fedeli, splendida attrice, donna dolcissima. Qualcuno gli disse, tempo dopo: “È Emma che te l’ha mandata Daniela”. Lo contagiai nella passione dell’incisione, scoprendo il suo talento anche in questo. Io facevo anche lo stampatore delle nostre opere e non riuscivo mai ad avere le mani pulite. Gli inchiostri sono micidiali. È estremamente affascinante l’incisione, con tante possibilità tecniche ma tutte estremamente complicate. Lastre da pulire impeccabilmente, affumicazioni, cere, punte d’acciaio, bulini, acidi, tarlatana per poupée, fogli di carta da bagnare e da asciugare, cartoni per spianarli, presine per afferrarli, registri, e poi finalmente il torchio che campeggiava nel nostro studio. Cominciavano le prove di stampa che potevano arrivare a essere tantissime, e ogni volta si ricominciava. Prima del Si stampi possono passare giorni, settimane, mesi, con un lavoro massacrante che ti assorbe completamente. Difficile coniugare prove a teatro, tournée, set, sale di doppiaggio. Dopo qualche tempo decidemmo di abbandonare“.
La tua relativamente recente carriera di pittrice e incisore ti ha portato a fare prestigiose mostre nei palcoscenici artistici più importanti d’Italia quali Venezia e Roma. Cosa rappresenta l’arte figurativa per te? Cos’è l’arte se ti venisse chiesto di definirla come sto facendo io adesso?
“Sì, facemmo altre mostre, tra cui quella alla Galleria Trifalco, nel cuore di Roma. Ricordo la direttrice, Giannina Angioletti, che si innamorò delle nostre opere. Preparammo un catalogo delle nostre incisioni con presentazioni di Cesare Zavattini, Ugo Gregoretti, Domenico Purificato, lo scenografo Eugenio Guglielminetti e il critico d’arte Duilio Morosini, che ci ricordava che si cominciò a “fare la critica” quando l’Arte entrò in una crisi profonda, per spiegare o elogiare l’opera di un artista. Lui alla definizione di critica d’arte preferiva quella di filosofia dello sguardo. Si considerava piuttosto un “interlocutore con un cervello diciamo normale e grandissimi occhi”. Non capiva “l’ideologo che non guarda le opere ma costruisce castelli di ipotesi”. Riteneva l’Italia il paese che produce ideologia più di ogni altro. Era molto critico nei confronti dei critici d’arte che basavano il loro mestiere sulla ideologia. Auspicava la concretizzazione di un Progetto di cultura globale che avesse in sé una visione allargata alle varie forme di cultura. Considerava, bontà sua, Armando e me come esempi di questo concetto perché ci esprimevamo “per via di azione scenica e simultaneamente per via di immagini”. Notò con un po’ di stupore quanto noi fossimo dissimili nei nostri stili pur lavorando fianco a fianco. Nessuno dei due era minimamente influenzato dall’altro. Partecipammo a collettive di prestigio accanto a nomi importanti di pittori e incisori come Virgilio Guidi, Luca Crippa, Armando Pizzinato, Elio Brombo; a Bolzano, Lyon, Mulhouse, Salzuflen“.
“Come si può definire l’Arte, mi chiedi. Direi che è un’attitudine di vita, che si applica alle cose che facciamo. Non voglio fare un discorso elitario. L’arte la può praticare chiunque, in qualsiasi campo. Arte è parola che si coniuga infatti con molte altre, potremmo dire in tutti gli ambiti della vita. Credo che scaturisca dalla creatività che in fondo accompagna l’uomo fin dalla nascita, e i bambini ne sono i maggiori… portatori. Svolgere un lavoro, qualsiasi lavoro, con arte, è il regalo più bello che ci si possa fare. Pensiamo agli occhi di chi termina un lavoro fatto… a regola d’are. Alla gioia che da quello sguardo traspare – e che è il coronamento a momenti di dubbi, spaesamento, di conflitti, di fatica della ricerca, di sofferenza quando l’ispirazione ci abbandona, di sconforto se ci assale la voglia di mollare tutto – quando riusciamo a esprimere quello che ci frulla nella testa, nell’anima e che vorremmo si tramutasse in qualcosa di compiuto attraverso un quadro, una musica, un libro, una messa in scena, un film. Ma anche coltivare un orto, è arte, confezionare un abito, fare un mobile. E si può continuare all’infinito. È un po’ come aver messo al mondo una creatura. Questo per dire che tutti possiamo essere artisti, dipende da come facciamo le cose e da quanto riusciamo a stare lontani da quel potere che ce la vorrebbe sottrarre, l’arte, perché lui l’ha rifiutata e ne ha paura, chiudendosi in una gabbia che forse mai si aprirà. Artiste erano le mondine che nell’‘800 in Piemonte – che si era impossessato anche del riso della Sicilia già patria de’ palle ‘e riso, le superbe arancina – comunicavano al padrone della risaia il loro scontento per essere pagate con un kg di riso al giorno. Sicuramente quei cori le aiutavano a vivere, almeno esprimevano il loro scontento per quel miserevole kg di riso. Il canto era la loro forma d’arte perché le aiutava a esprimersi, e quando uno riesce a esprimersi vive meglio. Con l’Arte ci si cura. E forse l’uomo nella sua travagliata condizione esistenziale ha continuo bisogno di cure. Più si è malati più si ha bisogno di cure, e chi più si cura con questa meravigliosa medicina, più ha la possibilità di vivere meglio. Certo non guarisce del tutto, anzi forse peggiora perché aumenta la consapevolezza di sé e del mondo con le sue storture, e a quel punto si ha bisogno di altra medicina, insomma è un po’ un paradosso. Sì forse l’arte è un paradosso. La ragione umana, o meglio il cattivo uso di essa ci distrugge, ci fa ammalare; l’arte ci salva, ci cura. Pensiamo a quei popoli primitivi che con il loro artistico folklore non avevano mai avuto bisogno dello psicoanalista. Ora purtroppo sono tutti spariti, e con loro il grandissimo folklore artistico; spazzati via, proprio da quei popoli la cui “ragione” si fece prepotente e soverchiante. Ma avevano anch’essi, i primitivi, la loro arte. L’aveva ben capito Pablo Picasso che rimase affascinato dall’arte negra e se ne fece influenzare tanto che arrivò a dire “L’artista crea, il genio copia”. Tutto questo per dire che l’arte è necessaria, come l’acqua, l’aria, la luce, cose senza le quali l’uomo morirebbe. L’arte è la nostra grande amica, la sorella che ci conduce per mano in questo viaggio terreno che ogni giorno affrontiamo con fatica. Arte significa Amore, le due cose sono inscindibili, perché è impossibile dedicarsi a qualcosa che ci sta a cuore senza amore – se hai coltivato un peperone con amore quell’amore arriverà sulla tavola di qualcuno. E aggiungerei Libertà, quella libertà necessaria, indispensabile per arrivare a trovare il modo di esprimere sé stessi“.
“Quanto all’arte figurativa credo che quel bambino che si era messo a disegnare, come fanno tutti i bambini, aveva capito che nel farlo ci provava un grande gusto e l’ha coltivato nel corso degli anni, fino a scoprire magari d’avere del talento. Paradossalmente abbino l’arte figurativa alla musica, le due primarie forme d’arte, pensiamo alle pitture rupestri e ai ritmi dei primitivi. Il bambino scarabocchia e fa rumore col cucchiaio della pappa; altra cosa che le accomuna è l’utilizzo delle mani“.
“Molti sono stati i movimenti e i pittori che hanno capito l’importanza della creatività primaria, intendo quella dei bambini, tanto da abbandonare il figurativo puro stravolgendone i connotati. Con i passi da gigante che faceva il progresso nell’‘800 forse si tentò nell’arte pittorica di recuperare qualcosa di molto antico, come se il progresso che si annunciava sfrenato mettesse paura. Nacquero le avanguardie, furono tanti i movimenti. Innovativi, trasgressivi, rivoluzionari. Per gran parte mi pare che oggi l’arte figurativa abbia capitolato lasciando il campo a tante altre possibilità di espressione dove la fanno da padrone appunto quel progresso e la tecnologia che fecero paura, forse non a torto. E poi l’arte è una grande forma di comunicazione e l’uomo se non comunica muore. Non sono un critico sto solo cercando di chiarire a me stessa le idee rispondendo alle tue stimolanti domande. Ci furono momenti di incredibile, sfrenata innovazione, le parole d’ordine erano denuncia, rabbia, rinnegare. Le classiche mostre si chiamarono performance. Si scagliavano colori, si dipingeva sdraiati per terra, si racchiudeva la propria merda in un barattolo e si esponeva, in tanti esemplari numerati. Ancora oggi costano un sacco di soldi. Due donne. Peggy Guggenheim, Palma Bucarelli dettero un impulso straordinario a questa rivoluzione inconcepibile. Due donne strepitose, affascinanti, intraprendenti, coraggiosissime“.
Charles Bukowski, grandissimo poeta e scrittore del Novecento, artista tanto geniale quanto dissacratore, in una bella intervista del 1967 disse… «A cosa serve l’Arte se non ad aiutare gli uomini a vivere?» (Intervista a Michael Perkins, Charles Bukowski: the Angry Poet, “In New York”, New York, vol 1, n. 17, 1967, pp. 15-18).
Tu cosa ne pensi in proposito. Secondo te a cosa serve l’Arte nelle sue varie declinazioni… visiva, cinematografica, della scrittura, del teatro, della scultura…?
“Certo che aiuta a vivere. Anzi a vivere meglio. È la nostra interlocutrice che non ci abbandona, se noi la accogliamo, è colei che ci sta accanto nella solitudine quando i nostri simili ci voltano le spalle. L’Arte semplicemente ci fa vivere perché se l’uomo non comunica muore. Con un quadro, un film, una pièce teatrale una scultura ecc. ecc. comunico il mio pensiero. Posso non aprire bocca, altri lo faranno al posto mio nei casi in cui l’opera iniziale abbia bisogno del veicolo della parola, ma il mio pensiero potrà raggiungere un numero altissimo di persone, spinte magari da quell’opera a discutere, analizzare, confrontare punti di vista diversi, e così le idee circolano, ne fanno nascere altre e la vita lascia la sua impronta e si rinnova. Inutile aggiungere che attraverso l’arte tutto il mondo del passato, di un passato anche molto molto lontano, ci comunica ancora tante cose il cui significato non si è ancora esaurito e mai lo sarà. L’Uomo è un animale che deve vivere in comunità. Da solo morirebbe. Certo ci sono i casi estremi, gli eremiti, ma questo è un altro discorso. Hanno scelto l’Universo come interlocutore. L’uomo è l’unico animale a possedere la parola, questo vuol dire che è inevitabile che comunichi con i suoi simili grazie a essa. Al di là della parola ci sono le varie forme d’arte, coltivate nel corso dei secoli e dalle quali l’uomo mai si separerà. Forme d’arte che hanno camminato a fianco delle innovazioni tecnologiche. Pensiamo al cinema. Scrittura, teatro, scultura, ci raccontano un passato anche molto lontano. Il teatro era il mezzo più formidabile per veicolare le idee. Migliaia di persone affrontavano viaggi lunghissimi a piedi, forse a cavallo, per raggiungere i grandi luoghi di aggregazione, gli immensi teatri per ascoltare cosa avevano da dire i grandi autori di teatro già molti secoli prima di Cristo. Imparavano cosa può succedere all’uomo attraverso trame affascinanti che si risolvevano in moniti perché non venissero travolti da quelle tragedie sempre pronte a verificarsi nella vita dei poveri mortali. Trame ferree, rigorosissime, storie inventate che raccontavano l‘uomo. Personaggi che divennero miti. Il pubblico restava affascinato e si tratteneva giorni per seguire le gare tra gli autori e conoscerne poi il vincitore. Era la Tv del passato, capace di parlare a tanti. Quel monito del teatro greco si ridusse tanti secoli dopo al monitor della Tv. Molto più comoda, questa. No lunghi viaggi a piedi o a cavallo ma un divano. E del monito del passato è rimasto solo il monitor, senza nessun intento di istruire. Ma nel frattempo c’è stato il cinema, altro grande mezzo di comunicazione che può prefiggersi il compito di una crescita formativa della società e l’allargarsi della conoscenza”.
Come definiresti il tuo stile artistico? C’è qualche artista al quale ti ispiri?
“Ho iniziato col figurativo. Mi sento vicina alla Nuova Oggettività, il movimento nato in Germania negli anni Venti Trenta e attivo per lungo tempo anche in Italia e negli USA. Arte degenerata per i tedeschi. I suoi esponenti dovettero tutti fuggire all’estero. Ammiravo e ammiro molto Christian Schad. La rappresentazione della realtà dove partecipazione e sentimento vengono azzerati. Una rappresentazione senza apporti estetici o ideologici. Una realtà rappresentata come la psicopatologia della società col fattore umano ridotto a oggetto per volere del potere che vuole azzerare l’uomo pensante con i suoi sentimenti, soprattutto quelli di opposizione, rivolta, ribellione. Non vuole la rivoluzione. Tutto è fermo, quasi glaciale. Con precisione maniacale affrontavo superfici di 1 metro x 1 metro e mezzo con una mina da disegno numero 0,5, la più sottile esistente. Soggetti che parlano della realtà circostante, la vita invivibile delle città, case-bunker con grosse lance al posto delle finestre, uccelli stritolati da tubi di acciaio, grovigli di macchine dove una mano gentile sta per azionare una leva. È il mio modo di raccontare disegnando dipingendo o incidendo, diverso nella forma dalla scrittura ma con le stesse finalità“.
Quanto sono importanti per essere definiti veri artisti, lo studio e la disciplina? Perché secondo te, un giovane che volesse lavorare nel mondo dell’arte deve studiare, perfezionarsi e fare esperienza?
“Perché sarà lui stesso che lo chiederà a sé stesso. Sarà per lui una istanza primaria. Non sarà nessun dottore a chiederglielo. Quindi sarà sempre alla ricerca di tutto ciò che lo possa arricchire, vorrà arrivare alla padronanza dei mezzi di quella disciplina per esprimersi al meglio, e sarà inevitabilmente un lavoro senza sosta, complesso, arduo. Ma un lavoro affascinante per lui. Non si chiederà a quale grado di successo arriverà, non gli interessa, il più grande successo per lui sarà confrontarsi continuamente con sé stesso prima che con gli altri, misurare l’intimo piacere di constatare i progressi, la gioia che gli verrà dall’aver superato uno scoglio insormontabile, d’aver conosciuto l’insondabile e di essersene impossessato. Ma l’artista non si laurea mai. Ha scelto un lavoro senza fine. L’artista non si riposa mai, non va mai in pensione. E forse questo gli allunga la vita“.
Chi sono stati i tuoi maestri?
“Tantissimi. Tutti. Si impara da tutti. Si impara soprattutto dalla vita. Quella che ti scorre davanti minuto per minuto, in qualsiasi posto e in qualsiasi tempo dell’esistenza. Mai chiudere gli occhi. Mai pensare che ormai si è imparato abbastanza. Anche un signore incontrato su un treno può essere un maestro. L’attenzione verso di lui ti farà scoprire le peculiarità di un personaggio che forse un giorno ti capiterà di mettere in scena. Si impara dalla sensazione che si prova una sera d’inverno tornando a casa dove sai che nessuno ti aspetta, forse vorrai scriverne in un romanzo, in una commedia, o farne una poesia. Si impara dalle nuvole che improvvisamente oscurano il cielo e la luce diventa plumbea e ti chiedi che colori userai per fissare su una tela quel momento. Osservare osservare. Occhi e mente rivolti a qualcosa andando a braccetto con la curiosità, altra grande maestra sorella dello spirito di osservazione: padre e madre dello spirito critico in una sorta di iperbolico incesto. In fondo è lei che ci guida. Per scoprire le cose, anche le più semplici, ma se ci metteremo il cuore e gli occhi si mostreranno ricchissime di significati, e potremo estrapolarli, ci potremo lavorare sopra, renderli unici, ottenere risultai espressivi che saranno solo nostri, mai prevedibili, banali“.
“Anche dai cattivi maestri si impara. Se vedi un cattivo attore potrai imparare da lui perché il personaggio che interpreta scricchioli in più punti e quali siano i difetti di quella costruzione che sta in piedi con difficoltà. Perché a forza di osservare e di essere curiosi, si sarà affinato anche lo spirito critico, non utile ma indispensabile per analizzare non solo i fatti artistici, ma tutto il complesso di accadimenti nei vari ambiti, non escluso quello politico. Poi certo di maestri in carne e ossa ne ho avuti molti. Orazio Costa Giovangigli che insieme a Andrea Camilleri teneva le lezioni di Recitazione; il docente di Storia del Cinema Fausto Montesanto che durante le proiezioni parlava parlava e io prendevo appunti al buio sul mio quaderno senza distogliere lo sguardo dallo schermo per spiegarci il perché per esempio Dreyer avesse girato la Giovanna d’Arco tutto in primi piani e di quale fosse stato poi il destino di Rainée Falconetti finita in manicomio per aver interpretato con tanta sconvolgente intensità e assoluta partecipazione quel difficile personaggio. Ci spiegava i movimenti di macchina, l’importanza del montaggio. È splendido il cinema muto. È l’immagine nella sua essenza. Privo di parola, privo di colori. Un pomeriggio venne dedicato a Kally Sambucini e Emilio Ghione, divi del muto interpreti in tanti film della coppia Za la Vie e Za la Mort. Vidi zia Kally, cugina di mia nonna Giovanna Sambucini che insieme a mia madre ogni tanto andavo trovare. Alla fine della proiezione il Prof Montesanto ci teneva sempre la porta aperta perché noi studenti uscissimo in fila. Quel giorno bloccai la fila, mi fermai e gli dissi: Sa professore, la Sambucini è mia zia. Rimase sbalordito, quasi non ci credeva farfugliò dei complimenti e con grande gioia mi abbracciò”.
“Ho cercato di apprendere da Marcel Proust a non avere paura della scrittura. Ad affrontare i momenti di difficoltà nel raccontare, a non fuggire davanti a una esposizione ardua, a non rifiutare un periodo lungo con incisi, rimandi, significati sottintesi, a ricorrere a una metafora. Sentirsi dire L’ho letto d’un fiato è sempre un complimento per l’autore, ma io devo confessare che quando leggo mi piace tornare su una frase, un periodo, per capirne bene la costruzione, il ritmo, così importante nella scrittura, e quel complimento mi fa pensare un po’ a una meravigliosa parmigiana di melanzane trangugiata e di cui forse mi sono persa qualcosa del prodigioso sapore di cui non conserverò memoria facendo gran torto a chi l’ha cucinata”.
Alcuni programmi televisivi italiani fanno passare l’idea che per diventare artisti o attori, basta solo avere fortuna ed essere lanciati dalla “notorietà social o televisiva”. Tu che ne pensi di questo fenomeno?
“Che è appunto un fenomeno. È ciò che appare e basta. E poi si sa, le tv sono mendaci. Certo molti ne sono attratti, la notorietà porta danaro, si è riconosciuti per la strada, il senso di vanità trova soddisfazione. Ma è un miscuglio di cose che può compromettere a volte la vita privata, con conseguenze spiacevoli, perché ci si è lasciati andare a uno strabismo pericoloso. Si è praticamente barattati sé stessi per vittorie fatue“.
Qual è il ruolo della critica cinematografica oggi? Quale dovrebbe essere a tuo parere il suo vero compito per promuovere la cultura della settima arte?
“La critica aiuta a capire. Il critico ne sa più di me di cinema, è questo il punto, tante cose possono sfuggire all’occhio del grande pubblico e il critico può farmi scoprire significati che mi erano sfuggiti. Certo non deve essere anch’essa ermetica ma si deve avvicinare al pubblico il più possibile, altrimenti abbiamo bisogno di un altro critico che spieghi il primo. Il linguaggio poetico dell’autore però non deve essere troppo criptico perché poi tanto c’è il critico che spiega. Trovo che l’ideale sarebbe che l’autore tenesse sempre presente che il pubblico è molto vasto, c’è il signore preparato e il signore meno, e che quello che vuole dire dovrebbe arrivare a più persone possibili, senza la stretta necessità del traduttore, senza che per questo lui, l’autore, si senta addosso nessuna costrizione. Non dimentichiamo che il cinema è la forma d’arte più popolare e che tutti possono, dovrebbero, usufruirne. E poi la critica deve essere libera. Non ci devono essere ragioni di mercato né il bisogno di allinearsi agli altri. A volte leggere critiche in contrasto tra di loro può essere molto stimolante“.
Seconde te Daniela, è importante partecipare a Festival del Cinema? Oggi in Italia ce ne sono tantissimi, non tutti di qualità, alcuni organizzati molto bene. Per chi fa cinema o scrive di cinema, a cosa serve partecipare ad un Festival del Cinema?
“Serve a tenere vivo l’interesse verso questa arte. È la più giovane che abbiamo, dobbiamo coccolarla. In fondo non sono che delle grandi feste, con più o meno dispendio di danaro ma questo non importa, e le feste sono sempre belle. La preparazione, le attese. Sono momenti di confronto formidabili da cui sicuramente nascono nuovi semi grazie ai quali il cinema si rinnova“.
Ci parli dei tuoi ultimi lavori e dei lavori in corso di realizzazione?
“Mi è stato da poco pubblicato un testo di teatro ispirato al mito di Medea. Ci ho girato intorno per anni. Tre anni fa finalmente l’ho scritto. Ho fatto di Medea una immigrata dall’Africa spinta sulle nostre coste dalla guerra che l’Occidente ha portato nel suo Paese, quello del popolo dei Tuareg. Considero Medea la prima immigrata della storia, anche se fu concepita da Euripide, nel 450 a.C., come frutto della sua fantasia, immigrata a causa della guerra per il potere. Moltissimi sono gli autori che hanno ripreso questo personaggio nel corso dei secoli. Ora mi ci sono aggiunta io eh eh. Ma gli antichi greci sono stati i nostri grandi maestri nell’indicarci tutti i possibili percorsi dell’uomo e della vita. Spero di riuscire presto a metterlo in scena. L’ideale sarebbe in uno dei meravigliosi teatri antichi di Sicilia. Per acquistare il testo pubblicato si può andare su IBS“.
“A breve sarà pubblicato anche il testo su García Lorca e girerò un corto. La storia di una donna il cui marito ha cancellato la sua vivezza che lei crede di ritrovare dopo un nuovo incontro, ma come succede spesso nella vita, tutto si rivelerà fasullo. A novembre organizzerò e curerò per il terzo anno “Festa alle donne” contro il femminicidio con una serie di corti teatrali. E poi vorrei presentare dei monologhi ispirati ai discorsi, ce ne sono di bellissimi e commoventi, dei nostri Padri e Madri della nostra Costituzione, per ricordare quanto sia importante rispettarla. Nota dolente della nostra società e della politica che ancora la tradisce“.
Immagina una convention all’americana, Daniela, tenuta in un teatro italiano, con qualche migliaio di adolescenti appassionati di teatro e cinema. Sei invitato ad aprire il simposio con una tua introduzione di quindici minuti. Cosa diresti a tutti quei ragazzi per appassionarli al mondo della recitazione, del teatro e della settima arte? Quali secondo te le tre cose più importanti da raccontare loro sul cinema?
“Beh, intanto dobbiamo trovare un teatro così grande. Ma va bene lo troviamo. Qualche migliaio di ragazzi mi farebbero tremare i polsi. Inizierei appunto col dir loro che mi tremano i polsi, glieli mostrerei porgendo loro il mio cuore nel ringraziarli d’essere venuti. Se sono lì immagino che un po’ di interesse per ciò che è teatro e cinema già lo abbiano. Spero solo di non farglielo passare. Sarebbe un delitto. Una colpa grave che neppure pagherei perché nessuno mi arresterebbe. Direi loro di guardare dentro di sé, con molta obbiettività e lucidità per capire se il loro desiderio di svolgere questo lavoro e non un altro sia sincero e appassionato. Chiederei loro, a ognuno di loro, di rispondere alla domanda: “Perché hai deciso di fare l’attore, o il regista, o di scrivere per il teatro?” ma mi rendo conto che per far rispondere qualche migliaio di adolescenti passerebbe troppo tempo. Certo sarebbe interessante conoscere le loro risposte. Sì perché me ne aspetterei delle più varie. Però li inviterei a farsela, questa domanda, credo importante. Potremmo valutare tutti insieme, e mi piacerebbe andare in mezzo a loro, se un così scombiccherato mestiere può essere il compagno di una vita. Fare teatro, fare cinema. È un po’ come vedere due fratelli di cui l’ultimo è nato tanto tempo dopo, molto desiderato, perché non si lasciasse il primo senza la compagnia di un parente stretto. Teatro e cinema sono due cose di grande impegno, questo lo devono sapere, e di grande lavoro che non termina mai, è una ricerca continua, dentro di sé e al di fuori di sé. Se non si ha consapevolezza di sé tutto diventa ancora più difficile. In fondo è un gioco, bellissimo e divertente, ma anche molto serio, anche sul piano pratico, lunghe prove, l’impeccabile memoria, la disponibilità a tutte le ore, le alzatacce del mattino. Possiamo raccontare la vita, con questo lavoro. Non è poco. Affondando le mani nella nostra fantasia per costruire trame, personaggi, situazioni e farne uno spettacolo, parola che contiene in sé il senso dell’osservare, del guardare; non farsi sfuggire nulla e arrivare al prodigioso. Sapere quali sono le nostre istanze. Perché si vuole raccontare quella storia? Cosa ci preme dire? Teatro, Cinema. Due lavori strettamente legati fra loro e interscambiabili ma con precise peculiarità. Le tecniche sono diverse ma si tratta sempre di raccontare. Ora la tecnologia ci aiuta, si possono vedere i grandi del passato che mai saranno sorpassati: sono delle vere miniere. A parte la scrittura teatrale che si fa in solitudine le messe in scena e il film hanno bisogno di tanti collaboratori, quindi mai pensare d’essere protagonisti, anche se recitando si è il protagonista. Trovare il giusto modo di relazionarsi con gli altri che ci lavorano accanto, tecnici e via dicendo, è molto importante. Perché in fondo è un lavoro corale. A chi avesse già deciso poi di fare del cinema ricorderei che il cinema è sogno. Non necessariamente in bianco e nero, anche se Pasquale Squitieri sul set de Gli invisibili alla mia domanda “Perché stai girando in b.n.?” rispose “Perché si sogna in b.n.” “Ma no Pasquale io sogno spesso a colori” ribattei. Mi guardò stupito”.
“Non so se di tutti quei ragazzi venuti alla convention ne sarà rimasto qualcuno. Forse non si sono annoiati ma addirittura spaventati; le tre cose che mi avevi chiesto tu Andrea sono diventate molte di più. Ma le cose difficili hanno un fascino particolare, spero di aver loro comunicato questo concetto. Non vorrei rischiare l’arresto“.
Dove potranno seguirti i tuoi ammiratori e i tuoi fan?
“Forse semplicemente su FB. È micidiale, non gli scappa niente.
Saluto tutti con molta simpatia, soprattutto quelli che hanno avuto la pazienza di arrivare fin qui.
E saluto te Andrea, Artista Scrittore di grande sensibilità“.