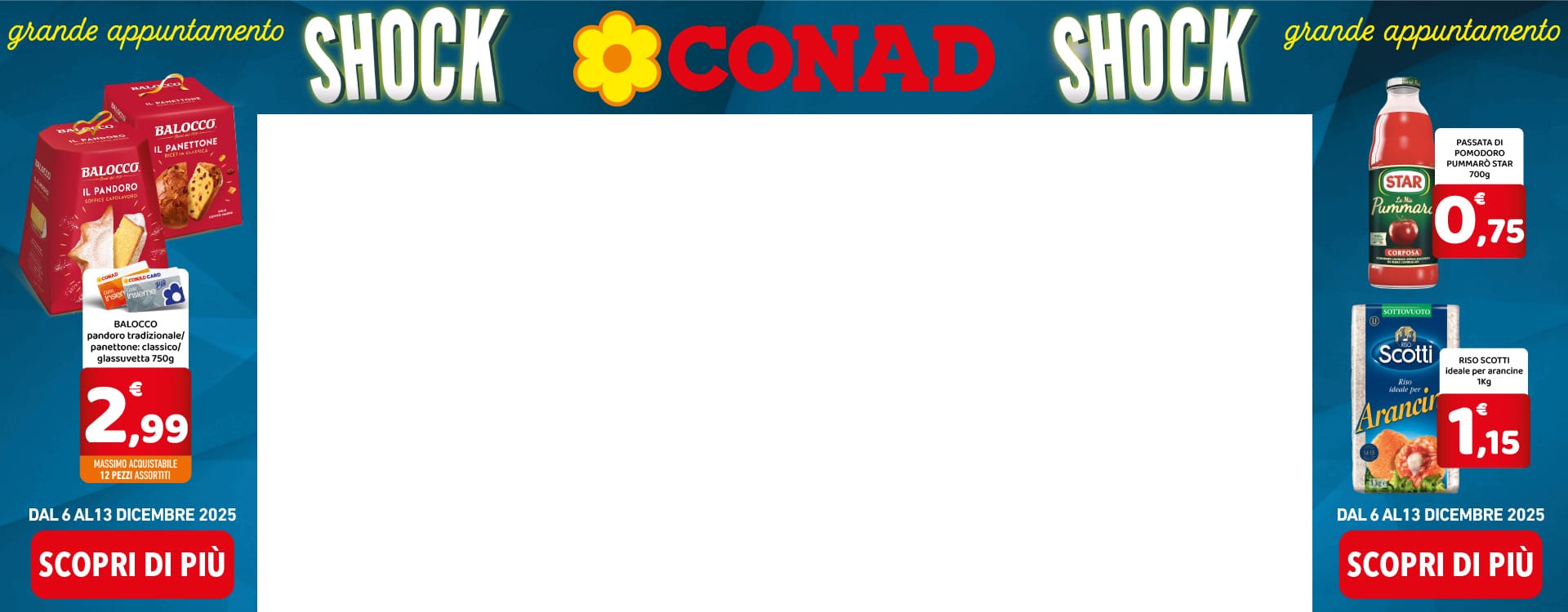“E dove sono adesso i tuoi sberleffi, le burle, le capriole, le canzoni, i folgoranti sprazzi d’allegria/ che facevano scoppiare dalle risa le tavolate?”, diceva Amleto al teschio di Yorick, il buffone di Corte.
E io dedico le stesse parole a Roberto Benigni, ‘morto’ forse da vent’anni, sicuramente da quindici, nonostante il suo simulacro talvolta ci appaia al cinema o in TV, travestito da guru. Il guitto non c’è più con quella corporalità da marionetta, le frasi sboccate, gli approcci ‘sessuali’ ai personaggi famosi. Al suo posto c’è un sosia coetaneo del de cuius che sembra una controfigura flaccida, irreggimentata, sedata nella sua sfrontatezza delle origini.
Sono lontani anche i tempi in cui si faceva beffa di un atletico Woytila come nel film “Il Pap’occhio”, perché è diventato anche vagamente baciapile: il dissacrante ‘piccolo diavolo’ del ‘modello Giuditta’, ahinoi, è ormai una figura anodina incapace di ironia e sberleffi. Non ho nulla contro le conversioni: ho amato quella dell’Innominato di Manzoni, quelle di Levin e Nechljudov di Tolstoj, soffrendo e gioendo con loro; sono affascinata da personaggi che rividero in modo deciso la loro vita nell’ottica della fede, come Enea Silvio Piccolomini, poi Pio II.
Al giorno d’oggi Giovanni Lindo Ferretti (cantante e leader dei CCCP – Fedeli alla linea, dei CSI e dei PGR) ha imbastito la propria vita alla luce di una conversione profonda e fortissima sulla quale non possiedo forse i mezzi spirituali per comprenderla; ma appare motivata, sincera, radicale, quantunque misteriosa ed enigmatica. Ma Benigni proprio non lo capisco.
Forse si matura, ci si avvicina alla vecchiaia e il pensiero lontano della morte si fa sempre più vicino, gli eroici furori scemano e gli incendiari e fieri diventano pompieri, tanto per parafrasare una canzone di Rino Gaetano. Peraltro, non voglio qui polemizzare sul cachet sanremese perché su questo troppo si è discusso, anzi, a tale proposito dichiaro che Sanremo non l’ho proprio seguito né tantomeno il monologo di Benigni che decantava amore e bellezza, con riferimento al “Cantico dei Cantici”. Preferivo quando Amore gli soffiava veramente nel petto, rendendolo caustico, arguto e irriverente.
Non lo seguo più da quando si è messo a recitare “La Divina Commedia”. Di dantisti autorevoli ne abbiamo abbastanza e, se vogliamo ascoltare un’interpretazione magistrale del capolavoro del Sommo poeta, possiamo prestare l’orecchio a Gassman, Albertazzi o Bene. Come del resto è risaputo che molti tra quei bischeri dei toscani – anche tra gli appartenenti ai ceti popolari – siano soliti conoscere Dante a memoria, sicché non credo che egli abbia apportato nulla di nuovo.
Nulla di nuovo, ecco il punto nodale della mia riflessione: Benigni non ha più niente da dire di veramente suo. Lo dico con rammarico, come un’amante sedotta e abbandonata, perché, lo ammetto, lo amavo davvero tanto. Ma il caso di Benigni è solo un paradigma per leggere un atteggiamento umano, quel giro di boa dei ribelli che diventano reazionari: il guitto piaceva a tanti prima, ma erano sicuramente pochi rispetto all’ampio pubblico di benpensanti oggi trascinati dal guru, perché adesso si è pacificato, è l’eretico redento che si è assiepato ai valori di cui lo stesso pubblico vuole sentire parlare; è come un agitatore proletario barricadiero, trasformatosi negli anni in un rampante yuppie che ha sposato quei valori piccolo-borghesi un tempo dissacrati.
Nel suo anticonformismo odierno ritrovo invece i solchi radicati di un conformismo lezioso, scozzonato dai buoni sentimenti, mentre prima ci vedevo scontro, emozioni vivide e carnalità. E un’altra domanda mi sovviene alla mente: ma davvero abbiamo bisogno di guru che vengano a farci la lezioncina e il predicozzo su cosa debba essere l’amore? Perché tutta questa decantata armonia? L’amore può anche essere conflitto, ferita, dissonanza e sofferenza. Che ci faccia scegliere cosa debba essere per noi, visto che declama tanto anche la libertà.
Penso ad altri personaggi famosi e non: Celentano, da voce della canzone italiana – e Bingo Bongo – a guru con platea; penso a chiunque si erga su un pulpito, palco o cattedra che stia a decantarci, insegnarci come dovremmo vivere. Ne ho conosciuto uno nella realtà. Un docente dell’università tal dai tali che con i suoi discorsi a volte mistici, altre morali attirava studentesse più o meno sprovvedute alla sua Corte, predicando socraticamente bene e virtù, cristianamente amore e rispetto, e per contro interpretando furbescamente il darsi e il donarsi, quei precetti all’apparenza fondati sulla comprensione dell’altro da te. Quando un artista o un pensatore diventa arido e non trova più nulla da dire potrebbe anche scegliere di sedere in tribuna, potrebbe scegliere il silenzio. Anche qui gli esempi sono numerosi e per tutti i gusti, ma ne farò pochi: Lucio Battisti e Francesco Guccini. Per non parlare di uno dei vertici di irripetibile poesia, cioè Arthur Rimbaud. Il resto sono solo ciance, maschere patetiche imbrattate, vernice lucida sulle crepe di un palazzo scricchiolante.