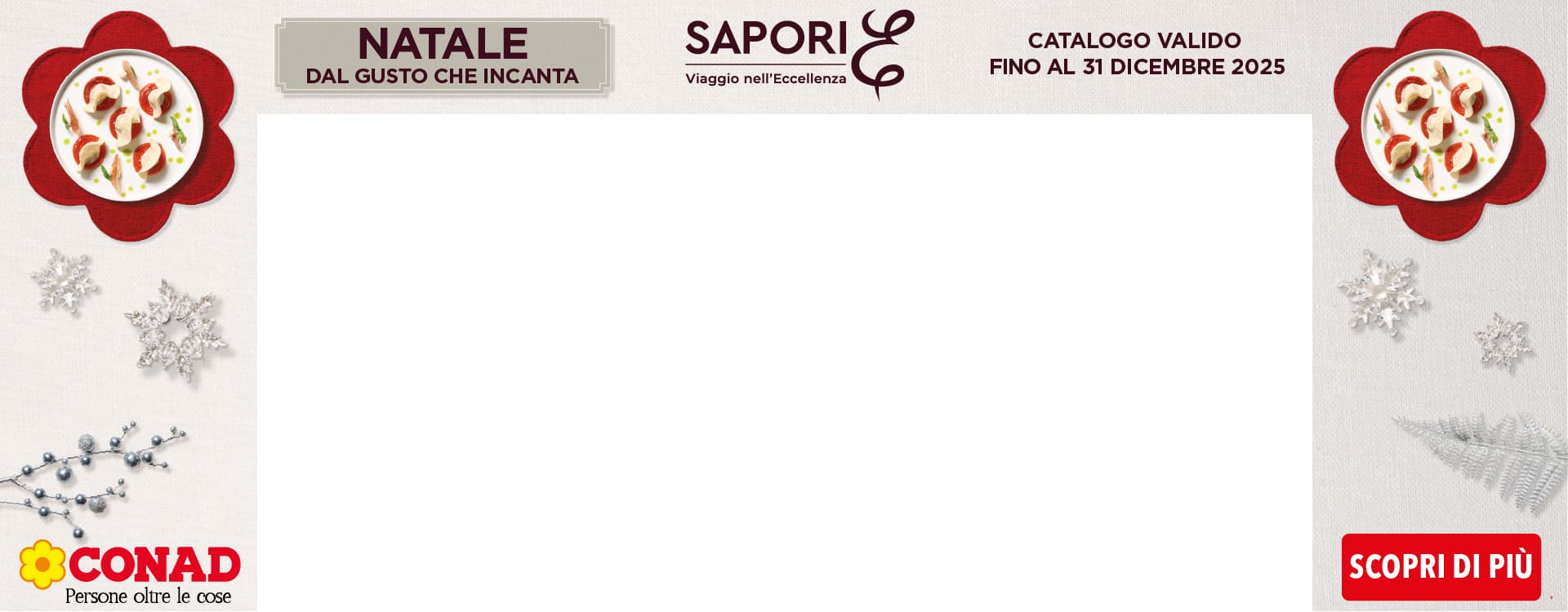La donazione del corpo alla scienza rappresenta un atto di grande valore per la ricerca medica e la formazione accademica. Tuttavia, in Italia, la normativa che regola questa possibilità presenta numerose criticità che ne ostacolano l’effettiva applicazione e diffusione. La legge 10 del 2020, implementata con un decreto attuativo nel 2023, si scontra con una serie di problematiche che vanno dalla scarsa informazione alla rigidità burocratica, fino ad alcune incoerenze normative che ne limitano l’efficacia.
Nonostante possa suscitare interrogativi etici o emotivi, la donazione del corpo alla scienza rappresenta comunque un contributo insostituibile per il progresso della medicina. Chi decide di compiere questo passo offre un dono prezioso, che ha il potenziale di migliorare le cure e salvare vite nel futuro.
In Italia questa pratica è quasi inesistente e, per questo motivo, il nostro Paese è uno dei principali importatori di preparati anatomici e cadaveri ai fini di ricerca.
Nelle grandi città italiane viene donato in media un corpo all’anno: cifre ridicole in confronto a tanti altri Paesi, in primis gli Stati Uniti (leader del mercato di cadaveri a scopo di ricerca e principale fornitore per l’Italia insieme alla Germania), ma anche rispetto ai “vicini di casa” come l’Austria. Comprare una testa umana o altri preparati per la pratica medica e la ricerca non ha un costo basso, basti pensare a quelle che potrebbero essere le necessità per il trasporto, ben diverse dallo spedire un capo di vestiario o un libro acquistato su un qualsiasi sito di eCommerce.
E non si tratta solo di un problema economico, che comunque impatta notevolmente sulla gestione dei corsi di medicina, ma mancano anche le strutture per la gestione di questi corpi e, di conseguenza, i nostri studenti preferiscono andarsene all’estero, al contrario di quello che succedeva nel Cinquecento, quando l’Italia era la culla degli studi anatomici mondiali, con frotte di studiosi che accorrevano per migliorare le loro competenze.
La disinformazione
“Il problema maggiore della legge 10 del 2020, che è quella che appunto stabilisce il modo in cui un soggetto può donare il proprio corpo alla ricerca scientifica o alla didattica, è informativo. La legge prevede un’informazione capillare ai cittadini, ma nella realtà questa informazione è del tutto assente. Già il sistema informativo sui trapianti è carente, figuriamoci quello sulla donazione del corpo alla scienza”, spiega Giuseppe Giaimo, professore ordinario di Diritto privato comparato del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo.
“Il decreto attuativo del 2023 è estremamente vago, lasciando alle aziende sanitarie il compito di informare, ma senza specificare come e con quali strumenti- prosegue -. Il risultato? Nessuno sa di questa possibilità. Se ne sei a conoscenza, probabilmente è perché lavori nel settore o ti sei informato autonomamente. La gente comune ignora completamente questa opportunità. Ma i problemi non sono solo informativi. La legge non prevede la possibilità di destinare il proprio corpo a un particolare centro o a una specifica ricerca. Io potrei voler donare il mio corpo per lo studio di una malattia che mi ha colpito in vita, eppure in Italia non posso farlo. Qui vige il criterio della prossimità territoriale: il tuo corpo andrà al centro più vicino, indipendentemente dalle tue volontà”.
La complessità burocratica e l’obbligo del fiduciario
“Il processo di donazione è reso ancora più complicato da una serie di passaggi burocratici che scoraggiano i potenziali donatori – evidenzia –. Per esprimere la volontà di donare il corpo è necessario un atto pubblico, una scrittura privata autenticata o un documento firmato e depositato presso la casa comunale. Inoltre, è obbligatorio nominare un fiduciario, il cui unico compito è informare il medico che constata il decesso dell’esistenza della volontà di donazione. Questa figura non ha alcun potere decisionale, quindi non è chiaro perché debba essere maggiorenne e capace di intendere e volere. Tale requisito sembra solo aggiungere un ulteriore ostacolo burocratico, senza una reale necessità pratica”.
Le restrizioni
“Un’altra criticità riguarda le limitazioni imposte dalla legge sui soggetti idonei alla donazione, da una parte giustificato per questioni sanitarie, dall’altra riflettere un pregiudizio culturale piuttosto che una reale esigenza scientifica – aggiunge –. Ma il punto critico, specialmente per i centri di riferimento e le università, riguarda la gestione del corpo dopo il suo utilizzo. La legge stabilisce che, dopo un anno di utilizzo per la ricerca o la didattica, i resti devono essere restituiti alla famiglia in “condizioni dignitose”. Tuttavia, il concetto di “condizioni dignitose” è estremamente vago e soggettivo. Un familiare potrebbe accettare il corpo con qualche segno del suo utilizzo scientifico, mentre un altro potrebbe aspettarsi una restituzione praticamente intatta. Questa ambiguità potrebbe generare contenziosi legali che rischiano di scoraggiare i centri di ricerca dall’accettare le donazioni”.
Il confronto con l’estero
“In Olanda è completamente diverso. Lì esiste una banca dati nazionale, e i cittadini possono scegliere a quale centro destinare la propria salma e per quali finalità. Si può persino parlare direttamente con i ricercatori per sapere come verrà utilizzato il proprio corpo. Questo incentiva enormemente le donazioni, mentre in Italia la nostra legge, pur con le migliori intenzioni, finisce per scoraggiare più che promuovere”.
Le speranze per il futuro
Guardando avanti, l’auspicio è che il sistema italiano possa evolversi per garantire maggiore efficienza e trasparenza nella donazione dei corpi alla scienza. Sarebbe fondamentale adottare un sistema più funzionale, anche prendendo gli esempi dove i corpi donati alla scienza sono maggiori. Inoltre, una campagna informativa capillare potrebbe sensibilizzare l’opinione pubblica e aumentare il numero di donazioni. Infine, è essenziale che le università e i centri di ricerca italiani abbiano accesso a un numero adeguato di corpi, evitando la necessità di importazioni dall’estero e garantendo una formazione medica di qualità.
“Oggi esistono tecnologie avanzate, modelli 3D e simulazioni digitali, ma niente può sostituire la realtà del corpo umano – conclude Giaimo –. Un futuro chirurgo deve esercitarsi su veri tessuti, veri organi. La legge dovrebbe agevolare questo processo, non ostacolarlo. Inoltre, la donazione dei corpi rappresenta un atto di grande valore sociale, poiché contribuisce al progresso medico e scientifico, offrendo benefici non solo ai futuri professionisti della salute, ma all’intera comunità”.